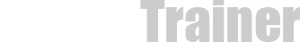Il Cinema in costume di Alessandro Blasetti: La cena delle beffe
A trenta anni di distanza dalla morte di Alessandro Blasetti (Roma, 1900 - ivi, 1987) si parla poco di lui. Per evitare che la sua versatile figura cada nel dimenticatoio, è giusto rendergli omaggio con uno dei suoi film più famosi, ovvero La cena delle beffe.
All’inizio della sua carriera, Blasetti fu un brillante critico cinematografico per quotidiani e riviste; ma, ben presto non esitò a mettersi dietro la macchina da presa, divenendo uno dei più valenti registi italiani durante il ventennio. Fondò la casa di produzione Augustus e realizzò la sua prima opera: Sole, ispirata ai capolavori di Sergej Michajlovic Ejzenstejn. Da qui in poi nella sua filmografia troviamo i più fantasiosi e disparati esempi di cinema: commedie brillanti, kolossal, trilogie in costume, documentari, film di matrice letteraria, etc.. A soli trenta anni, egli venne chiamato da Anton Giulio Bragaglia a costituire la Scuola Nazionale di Cinematografia, dove insegnò. È doveroso, pertanto, riconoscere in lui il padre del nostro cinema.
Nel 1941 Blasetti vinse la Coppa Mussolini per il miglior film italiano all’IX Mostra del cinema di Venezia. È probabile che in seguito alla proiezione lagunare, la pellicola sia stata ridotta da 3600 metri agli attuali 2900 metri circa; tuttavia, tale voce è sempre stata categoricamente sconfessata dal regista. La trama ruota intorno a un tirannico e brutale autocrate interpretato da Gino Cervi. Eppure, Blasetti ha sempre stimato La corona di ferro una favola pacifista, un manifesto dell’antibelligeranza presentato sugli schermi internazionali proprio negli anni in cui l’Italia entrava in guerra al fianco degli alleati tedeschi. Che la pellicola sia contraria alla violenza, lo s’intende già nel momento in cui a vincere sono coloro che non usano armi letali, bensì la forza dell’intelligenza e del coraggio: per cui Arminio pur avendo la meglio sul re barbarico non lo uccide, ma si accontenta di disarmarlo. Proprio per la sua natura antimilitarista, il lungometraggio venne stroncato dal ministro della propaganda del III Reich Joseph Goebbels.
Allo stesso anno de La corona di ferro risale anche l’ultima pellicola in costume del regista romano (altre sono Ettore Fieramosca e Un’avventura di Salvator Rosa), ovvero La cena delle beffe. In verità, Blasetti confessò in un secondo momento di aver realizzato il film solo per “rispondere” ai critici che avevano disapprovato il suo precedente lavoro e per offrire un ruolo di co-protagonista a Osvaldo Valenti, segregato da sempre in piccole parti da villain.
Il lungometraggio, liberamente tratto dall’opera drammatica in quattro atti di Sam Benelli, è ambientato nella Firenze di Lorenzo il Magnifico. Nel film non vi è una netta corrispondenza tra l’ambientazione in cui si svolge la storia, ovvero Firenze, e il parlato. Seppur si riscontrino tratti riconducibili alle varietà toscane, specie nella scena dell’osteria di Ceccherino, la vicenda potrebbe avvenire in qualunque altro luogo dell’Italia rinascimentale. Ne consegue che l’uso della lingua non venne impiegato da Blasetti per esigenze di puro realismo.
I personaggi principali della vicenda sono: Neri Chiaramentesi (Amedeo Nazzari) e Giannetto Malespini (Valenti). Entrambi sono follemente innamorati della voluttuosa cortigiana Ginevra (Clara Calamai). Ma, mentre il primo è giovane e forte, l’altro ostenta ambiguamente caratteri femminei. In più, Giannetto è nauseato dai continui sberleffi e ingiurie che deve subire da parte del fanfarone Neri. Decide perciò di passare all’attacco. Durante un simposio - la cena delle beffe per l’appunto - l’uomo, in vena di vendetta, propone a Chiaramentesi di recarsi in una malfamata bettola fiorentina con una pesantissima armatura in corpo e una roncola nelle mani. Neri accetta di buon grado la proposta; ma, giunto sul luogo viene arrestato e condotto nei sotterranei del palazzo dei Medici. Lo si accusa di squilibrio mentale. In realtà, niente di tutto ciò è vero; anzi. Si tratta di una maldicenza messa in giro dallo stesso Malespini. Una volta acciuffato, il giovane è sottoposto alla pubblica gogna, Nel frattempo, Giannetto possiede Ginevra. Ritenuto dalle autorità non pericoloso, Neri viene lasciato libero e gli viene accordato il permesso di far ritorno a casa. Quella stessa notte, l’uomo medita un piano per regolamentare i conti: si reca dalla bella cortigiana e, appostatosi nella sua camera da letto, attende l’arrivo del rivale per poterlo uccidere. Non appena Giannetto entra nell’alcova, il Chiaramentesi balza su di lui e lo pugnala; ma, ahimé, non è ill vile Giannetto (che aveva presagito le future mosse dell’altro), piuttosto di Gabriello, fratello di Neri. Resosi conto del fatale equivoco, il giovane impazzisce davvero.
Sin dalla sua uscita sullo schermo, La cena delle beffe fu un facile bersaglio del Centro Cattolico Cinematografico, che così giudicò l’opera: “un intreccio di libidine, di brutalità e di libertinaggio rendono, in sede morale, un film deplorevole e, pertanto, da escludersi per ogni genere di pubblico”. Il Ministero della Cultura Popolare, rendendosi conto dell’estrema licenziosità d’alcune scene, diede ordine di vietare la visione ai minorenni. La causa per cui il film venne stimato osceno è fondamentalmente collegata al fotogramma in cui appare il seno nudo della Calamai. Mai prima di allora lo spettatore italiano aveva visto una donna discinta sul grande schermo; quindi, Blasetti fu il primo ad aver scoperto il petto femminile in un’opera europea. Ma, l’alta componente sessuale della pellicola non è accertabile esclusivamente nel corpo svestito o ricoperto di semplici veli di Ginevra; infatti, ben più persuasiva è la malcelata attrazione omosessuale che lega fra loro Giannetto e Neri. Invero, i due uomini pur dichiarando il loro amore per la cortigiana, palesano (soprattutto nella scena finale) inconfessabili tendenze, tutto altro che eterosessuali. Del resto, a destare sospetti concorrono anche vari aspetti della personalità dei due protagonisti: se infatti da un lato vi è la virilità di Neri dall’altro, viceversa, si riscontra l’ambigua debolezza che pervade l’indole del Malespini. Per questo, il messaggio ultimo de La cena delle beffe è chiaramente misogino, dal momento che indirizza le simpatie del pubblico verso il Chiaramontesi per via delle sue qualità mascoline, mentre il suo antagonista è bollato come un degenerato a causa dei suoi attributi femminei.