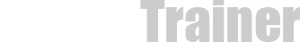La scuola cattolica: il delitto del Circeo raccontato da Stefano Mordini tra alti e bassi
Presentato Fuori Concorso alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e in sala dal 7 ottobre 2021, distribuito da Warner Bros. Pictures, La scuola cattolica di Stefano Mordini affronta il delitto del Circeo, basandosi sull'omonimo romanzo di Edoardo Albinati.
Siamo a metà anni Settanta, in quella Roma bene popolata di giovani facoltosi, con famiglie altolocate alle spalle e un futuro praticamente già scritto. In una rinomata scuola cattolica maschile, i ragazzi frequentano le lezioni e modellano le loro personalità in base agli esempi adulti che incontrano. Il percorso che li condurrà a diventare adulti si compone di genitori, insegnanti, figure che in qualche modo dovrebbero fungere da riferimento. Ma che, in qualche raro e terribile caso, avvallano certi comportamenti, quasi giustificandoli o fornendo addirittura moventi.
Quanto accaduto nella notte tra il 29 e il 30 settembre 1975 trascende il concetto di umanità, contaminandolo senza possibilità di recupero e mostrando le falle di un sistema che si pensava perfetto.
Nel raccontare la tragica vicenda, il cui valore è fuor di dubbio, il film – e prima ancora il libro che è una sorta di memoir – lavora sulle coscienze del suo pubblico: improvvisamente messi di fronte alla violenza, alla brutalità, all'incomprensione, ci si trova a dover gestire una gamma di emozioni che vira inevitabilmente verso la rabbia, l'indignazione, lo sconcerto. La discussione è uno degli effetti più potenti e pregevoli derivanti da La scuola cattolica, ed è ciò che lo rende forse un titolo adatto a essere proposto nelle scuole. Inutile sottolineare la necessità di una figura che ne guidi la visione, il confronto, il dialogo.
Se l'importanza di simili progetti sta appunto nel loro lascito, è fondamentale saperne trattare ogni più piccolo aspetto con accuratezza, sensibilità, attenzione. Mordini restituisce il clima dell'epoca, componendo gli anni Settanta attraverso il suo intramontabile stile, tra look e hit songs. La voce fuori campo di uno dei protagonisti (Emanuele Maria di Stefano), che veste i panni del reale Edoardo Albinati, introduce in questo mondo fatto di apparenza, di ipocrisia, di classismo.
È così che la parte iniziale della pellicola risulta la più riuscita, compatta ed elaborata. Mentre sembra sfilaccairsi via via che ci si addentra nella vera e propria tragedia. Il contesto storico, ricco di suggestioni e stratificazioni delle più eterogenee, non viene mai messo sotto la luce dei riflettori, facendo avvertire delle lacune imperdonabili. Lo stacco tra prologo ed epilogo destabilizza, e ne risultano quasi due sezioni distinte l'una dall'altra – la seconda non supportata da una base abbastanza solida.
Peccato perché la storia avrebbe meritato sicuramente un trattamento più strutturato, forte anche delle oltre 1000 pagine di romanzo. Al tempo stesso anche il cast, per lo più composto da volti giovani e poco noti (i più famosi sono forse Benedetta Porcaroli e Giulio Pranno), non riesce a sostenerne la complessità. Alcuni cruciali personaggi non hanno nemmeno una degna presentazione, comparendo sulla scena in maniera improvvisa e spiazzando con la fumosità che si portano dietro. A nulla possono più navigati, quali Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca, i cui ruoli sembrano semplicemente (e tristemente) tagliati con l'accetta.